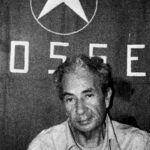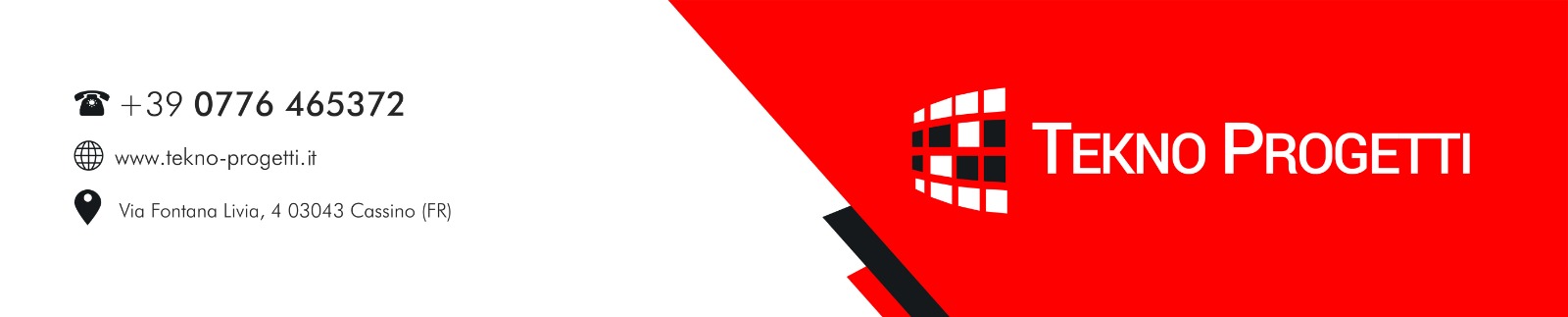- Emergenza Climatica: Dalla Verità dei Dati all’Azione Concreta per i Territori - 3 Luglio 2025; 19:30
- San Giorgio a Liri: 400 firme contro la cava d’argilla in località Morelle, cittadini e ambientalisti chiedono no alle nuove estrazioni - 3 Luglio 2025; 17:29
- Caira senz’acqua: Luca Fardelli, consigliere comunale: “Servono interventi strutturali, non più soluzioni tampone”. - 3 Luglio 2025; 11:06
L’editoriale del direttore
Il recente intervento del generale Mario Mori, ex colonnello del ROS e figura di spicco nei servizi segreti civili, davanti alla commissione Antimafia ha sollevato un ampio dibattito riguardo le dinamiche politiche e operative nella lotta contro la mafia in Italia. Le sue dichiarazioni, in particolare quelle riguardanti le pressioni subite che lo avrebbero indotto a desistere dalle indagini su mafia e appalti, pongono interrogativi fondamentali sul ruolo delle istituzioni e sulla trasparenza delle operazioni di polizia.

La prima domanda che sorge spontanea è: chi, e con quali motivazioni, ha esercitato pressioni su Mori per interrompere le indagini? È possibile che vi siano stati interessi politici o economici in gioco, capaci di influenzare le scelte operative delle forze dell’ordine? Queste considerazioni portano a riflettere su un possibile collusione di poteri che, pur di mantenere uno status quo, possano aver ostacolato la lotta contro la mafia.
In un contesto così complesso, è inevitabile chiedersi anche perché, nonostante le evidenti opportunità di cattura, non siano state effettuate perquisizioni decisive. Per esempio, perché Mori non abbia perquisito il covo di Totò Riina dopo il suo arresto? Cosa ha impedito la cattura di Bernardo Provenzano, nonostante l’infiltrazione di Luigi Ilardo avesse fornito indicazioni preziose sulla sua posizione? Queste domande non sono solo retoriche; esse cercano di mettere in luce le lacune operative e strategiche che potrebbero aver compromesso la lotta contro la mafia.

La questione dell’inefficienza delle forze dell’ordine non è nuova, ma le parole di Mori riaccendono il dibattito su un sistema che, in diverse occasioni, sembra aver fallito nel proprio dovere. In questo contesto, è lecito domandarsi se esista un vero e proprio piano a lungo termine per combattere la mafia, o se piuttosto si agisca solo in risposta a eventi emergenziali, senza una visione strategica chiara.
Un altro aspetto da considerare è la gestione della comunicazione e della trasparenza all’interno delle istituzioni. La rivelazione di Mori porta con sé un’altra domanda cruciale: come si possono garantire al pubblico la verità e la responsabilità nel perseguire la giustizia? In un Paese dove la mafia ha radici profonde, la fiducia nelle istituzioni è fondamentale per mobilitare l’opinione pubblica contro la criminalità organizzata.
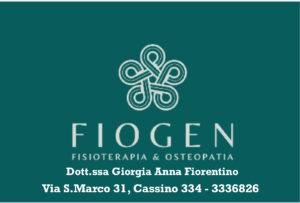
Infine, la testimonianza di Mori ci invita a riflettere sul futuro della lotta alla mafia: quali lezioni possiamo trarre da questo passato per evitare che simili errori si ripetano? È possibile immaginare un sistema di controllo e verifica che possa prevenire pressioni esterne sulle indagini? La risposta a queste domande non è solo una questione di giustizia, ma un passo fondamentale verso la costruzione di una società più equa e libera dall’influenza mafiosa.
In conclusione, l’intervento di Mario Mori, lungi dall’essere un semplice racconto di difficoltà personali, rappresenta un richiamo a una riflessione collettiva sull’impegno e la responsabilità di tutti nel combattere un fenomeno che continua a minacciare la nostra democrazia.